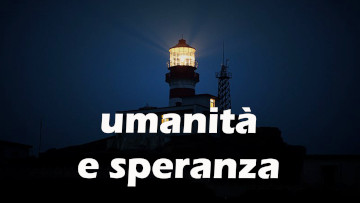Nell’antichità, all’età della pietra, gli esseri umani avevano bisogno di spostarsi da un luogo all’altro secondo la stagione per portare i loro greggi in cerca di pascoli freschi e acqua. La transumanza era diffusa a quei tempi. Non c’erano confini, né Stati, né regni, quindi spostarsi era naturale e non veniva penalizzato.
Storicamente, la transumanza è stata una parte importante dell’economia e della cultura di molte regioni del mondo, soprattutto in quelle aree in cui l’agricoltura non era praticabile tutto l’anno a causa di condizioni climatiche estreme o di limitazioni del territorio. La transumanza non riguardava solo lo spostamento degli animali, ma aveva anche implicazioni culturali, sociali e ambientali.
C’era uno scambio di costumi, conoscenze e lingue. Influenzava la formazione di identità regionali e la conservazione di conoscenze tradizionali sulla gestione del bestiame e dell’ambiente.
Non esiste un essere umano puro
Recenti studi sul DNA dell’Homo sapiens moderno dimostrano che non esiste un essere umano puro: tutti noi portiamo nel nostro DNA un’eredità ancestrale. Siamo figli della terra e come tali abbiamo ereditato conoscenze e costumi ancestrali dai nostri antenati.
La migrazione nel XXI secolo è stata guidata da una serie di fattori complessi e interconnessi, simili alla transumanza. Tra le ragioni principali vi sono conflitti e crisi umanitarie.
Conflitti armati, violenza politica e disastri naturali hanno causato lo sfollamento di milioni di persone in tutto il mondo. Paesi come l’Ucraina, Israele, la Palestina, la Siria, l’Afghanistan, lo Yemen e il Venezuela hanno vissuto conflitti interni prolungati che hanno costretto molte persone a fuggire dalle loro case in cerca di sicurezza e rifugio in altri Paesi. Gli esseri umani hanno trovato necessario migrare verso territori più promettenti e con maggiori prospettive per il futuro, dove potersi stabilire, sviluppare e contribuire al luogo con le loro migliori credenze e stili di vita. È questa diversità che rafforza una società, rendendo il gruppo umano migrante un creatore di opportunità di lavoro e un promotore dell’innovazione e del cambiamento tecnologico in molti momenti della storia.
I miei nonni erano emigrati dal Libano dopo la caduta dell’Impero Ottomano nel 1920. Arrivarono in Cile alla ricerca, come tutti i migranti, di maggiori opportunità di sopravvivenza. Approdarono solo con i vestiti che avevano addosso e iniziarono una nuova vita, e all’epoca lo Stato cileno e il suo popolo li accolsero, dando loro nuove identità e nuove opportunità di lavoro. Si verificò una fusione culturale: assimilarono la lingua e, a loro volta, miscele di sapori culinari che si intrecciarono con i nostri.
È chiaro che per costruire ponti tra culture e persone diverse è essenziale valorizzare e rispettare le loro peculiarità. L’importanza di comprendere, riconoscere e apprezzare le diverse culture, tradizioni e storie che ci circondano sarà una via d’uscita. Questo processo ci permette non solo di colmare le nostre differenze, ma anche di valorizzare i nostri punti di forza individuali e di trovare un terreno comune che ci unisca.
Ognuno di noi ha la capacità di contribuire in modo unico al raggiungimento di obiettivi comuni. È essenziale riconoscere come le nostre azioni e i nostri contributi possano avere un impatto positivo sul nostro ambiente e sulla realizzazione degli obiettivi comuni. In definitiva, l’apprezzamento reciproco è la base su cui possiamo costruire relazioni forti e collaborative, arricchendo così le nostre vite e le nostre comunità.
L’esistenza di una crisi del modello statale in quasi tutti i Paesi latinoamericani, accompagnata da disuguaglianze economiche e politiche, favorisce un piccolo gruppo privilegiato nella società. Questo genera un senso di insicurezza e di terrore e non fa che destabilizzare aree prive di violenza.
Gli Stati sono sempre più attenti alle migrazioni in tutto il mondo; la crisi umanitaria si è aggravata a tal punto che i poveri e gli svantaggiati stanno soffrendo di più. Inoltre, il cambiamento climatico ha esacerbato la crisi umanitaria. Gli Stati, più che mai, devono rendere flessibile un fenomeno che non sarà fermato da leggi discriminatorie che incoraggiano la xenofobia o con il blocco delle frontiere. Al contrario, devono promuovere la stabilità, l’istruzione e le opportunità di lavoro e ridurre i fattori che spingono alla migrazione forzata, permettendo così alle persone di scegliere se restare o emigrare.
Vorrei tornare a quei tempi in cui gli esseri umani potevano andare e venire liberamente come i figli della terra che siamo.
L’autrice: Viviana Galeb Adriazola, insegnante e poetessa cilena, nata nel 1956.
Traduzione dallo spagnolo di Thomas Schmid. Revisione di Mariasole Cailotto.