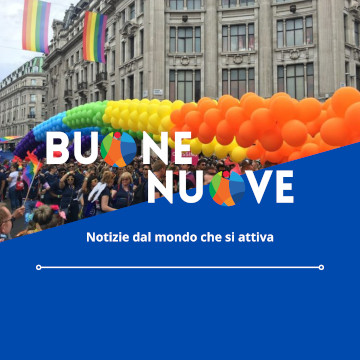Il 4 febbraio scorso è passato un anno esatto dalla tragica morte di Ousmane Sylla, giovane guineano di soli 20 anni. Si tolse la vita nel CPR di Ponte Galeria a Roma. Non è l’unico trattenuto in queste strutture ad averlo fatto, purtroppo, e soprattutto potrebbe non essere l’ultimo. Colpa di un sistema dolosamente fallimentare che non fa altro che alimentare disagi e dolore. E mentre continua il braccio di ferro tra la magistratura e il governo Meloni, con quest’ultimo che ventila l’ipotesi di trasformare anche i due centri di prima accoglienza in Albania in dei CPR, a Roma e in altre città italiane ci si stringe nel ricordo di Ousmane Sylla e si continua con la protesta. Quello dei CPR è un mostro burocratico le cui origini affondano in una stagione politica ormai lontana rispetto alla nostra, ma i cui effetti sono tutt’oggi drammaticamente tangibili.
La nascita del sistema CPR
Nel 1998 con la legge Turco – Napolitano furono introdotti i C.P.T. (Centri di Permanenza Temporanea) al fine di trattenere al loro interno le persone sprovviste di permesso di soggiorno e svolgere nel mentre le procedure necessarie ad effettuarne il rimpatrio. Successivamente i C.P.T. cambiarono più volte denominazione fino ad assumere quella odierna di C. P. R. (Centri di Permanenza per il Rimpatrio), ma l’aspetto su cui il legislatore è tornato più spesso nel corso degli anni è quello legato ai tempi massimi di trattenimento delle persone. Infatti, originariamente il termine massimo era di 30 giorni (art. 12 della legge Turco – Napolitano). La legge Bossi Fini del 2002 estese il termine a un massimo a 60 giorni. Successivamente una lunga serie di ulteriori modifiche alzò e abbassò il termine fino ad arrivare ai 90 giorni massimi previsti dal Decreto Lamorgese del 2020, prorogabili per altri 30 laddove la persona da espellere provenga da un paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi per la riammissione. Il Decreto Cutro nel 2023 ha poi ulteriormente alzato la proroga a 45 giorni.
Un altro aspetto critico della normativa riguarda invece la figura istituzionale preposta a stabilire se una persona sprovvista di un regolare permesso di soggiorno debba essere o meno trattenuta in un CPR. Tale figura risulta infatti essere il giudice di pace, il quale è un magistrato onorario, pagato a cottimo per ogni provvedimento che effettua e al quale il legislatore non ha assegnato la facoltà di comminare pene detentive. Oltre ad una figura istituzionale che dunque normalmente non giudica su materie così delicate che implicano il trattenimento e la restrizione delle libertà personali c’è da considerare inoltre i tempi medi delle udienze di convalida e proroga del trattenimento. Queste, infatti, non superano i cinque minuti di media, con tassi di approvazione che sfiorano il 100%, statistica che rende bene l’idea dell’arbitrarietà del procedimento con il quale si decide della libertà e del futuro delle persone.
Le strutture oggi
Il Decreto Minniti del 2017 permise il potenziamento della rete di strutture e ne aumentò il numero. Ad oggi, i CPR dislocati sul territorio italiano sono dieci e sono tutti collocati in aree extraurbane. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di strutture che erano già esistenti e che sono state riadattate per l’occasione. Il CPR di Nuoro, ad esempio, in precedenza era una struttura penitenziaria mentre quelli di Caltanissetta e Gradisca d’Isonzo erano caserme militari. Gli utilizzi precedenti di queste strutture suggerisce già il forte carattere securitario e detentivo che permea i CPR i quali risultano essere assolutamente impermeabili rispetto all’esterno. Le persone trattenute vivono in una condizione di privazione delle proprie libertà personali che è assimilabile a quella che vivono i detenuti di un carcere, con la differenza fondamentale che se per quanto riguarda gli istituti penitenziari è prevista una normativa in materia di controlli e garanzie minime circa il diritto alla difesa, l’accesso all’informazione, la comunicazione con l’esterno, nulla di tutto questo è stato previsto per i CPR. Chi finisce al loro interno si ritrova completamente isolato, sprovvisto di assistenza e spesso oggetto di ulteriori soprusi e vessazioni, come le tragiche storie di Ousmane Sylla e di molti altri. Non è un caso che spesso dentro ai CPR si verifichino rivolte, tentativi di fuga e gravi tentativi di autolesionismo, se non suicidio. È la condizione di sospensione tipica di questo genere di strutture, l’assenza di progettualità e il totale affidamento del destino delle persone a macchine burocratiche il cui unico e fondamentale fine è l’espulsione di queste, indipendentemente dal loro vissuto, strutture che schiacciano chi si trova al loro interno.
Le carenze del sistema CPR
Sulla carta i CPR avrebbero dovuto rispondere all’esigenza di trattenere le persone sprovviste di permesso di soggiorno il tempo necessario a svolgere le procedure amministrative per rimandarle nel paese di origine, ma di fatto le procedure per il rimpatrio sono assai difficili da completare, specie in assenza di accordi tra l’Italia e il paese di origine della persona da rimpatriare, eventualità non rara. Dunque, a seconda della nazionalità delle persone, le percentuali di completamento della procedura variano di molto, divenendo prossime allo zero nel caso di alcuni paesi (Yemen, Afghanistan, Somalia) dove, complice la situazione di grave instabilità, effettuare il rimpatrio risulta non fattibile, sia diplomaticamente che logisticamente. Ecco che allora molte persone si ritrovano di nuovo in strada senza documenti nel momento in cui scade il periodo massimo di detenzione e lo Stato non è riuscito a trovare una soluzione. Nel mentre la persona in questione ha vissuto per un lungo periodo di tempo in una condizione di totale isolamento e vulnerabilità, rinchiuso in una struttura i cui servizi sono carenti o nulli, e le possibilità di vedersi calpestati i propri diritti sono molto elevate.
Anche là dove i rimpatri vengono effettivamente effettuati non mancano le forzature. Il caso più eclatante è quello della Tunisia. In percentuale, i tunisini rappresentano il paese più “numeroso” tra i rimpatriati. La Tunisia, infatti, nonostante la complicata situazione interna, figura nella lista dei cosiddetti “Paesi Sicuri”, ovvero un elenco di paesi che secondo le valutazioni del governo giustificano il rimpatrio, dato che la vita della persona in questione non sarebbe a rischio se dovesse essere lì rimandata. Ennesima forzatura che porta a definire sicuro un paese non democratico e con molteplici problemi economici e di sicurezza nonché carente in termini di politiche per l’asilo e i diritti umani.
di Stefano Seppecher