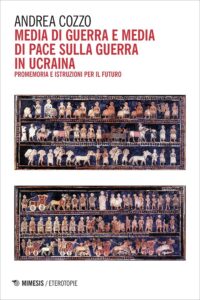 Viviamo tempi difficili, tempi che hanno riabilitato l’uso della violenza e rilegittimato la pratica della guerra. In questi frangenti, che possono rappresentare delle vere e proprie cesure storiche, è facile lasciarsi prendere dallo scoramento e dal disorientamento. Sono proprio questi i momenti in cui diventano salvifiche talune letture di libri che possono aprire nuove prospettive sul mondo e suggerire vie di fuga dal delirio guerresco del presente. Il libro di Andrea Cozzo, intitolato Media di guerra e media di pace sulla guerra in Ucraina. Promemoria e istruzioni per il futuro (Mimesis Edizioni 2025), ha il merito di associare alla denuncia dei responsabili dell’attuale stato di guerra e alla critica per chi alimenta, soffiando sul fuoco, un clima bellicista, una proposta di impegno attivo e militante per la pace; il suo è uno sguardo, disobbediente e empatico ad un tempo, che rappresenta anche un concreto e realistico programma per la realizzazione di un altro mondo possibile.
Viviamo tempi difficili, tempi che hanno riabilitato l’uso della violenza e rilegittimato la pratica della guerra. In questi frangenti, che possono rappresentare delle vere e proprie cesure storiche, è facile lasciarsi prendere dallo scoramento e dal disorientamento. Sono proprio questi i momenti in cui diventano salvifiche talune letture di libri che possono aprire nuove prospettive sul mondo e suggerire vie di fuga dal delirio guerresco del presente. Il libro di Andrea Cozzo, intitolato Media di guerra e media di pace sulla guerra in Ucraina. Promemoria e istruzioni per il futuro (Mimesis Edizioni 2025), ha il merito di associare alla denuncia dei responsabili dell’attuale stato di guerra e alla critica per chi alimenta, soffiando sul fuoco, un clima bellicista, una proposta di impegno attivo e militante per la pace; il suo è uno sguardo, disobbediente e empatico ad un tempo, che rappresenta anche un concreto e realistico programma per la realizzazione di un altro mondo possibile.
Cozzo insegna lingua e letteratura greca all’Università degli Studi di Palermo ma per chi, come il sottoscritto, lo conosce da più di trentacinque anni, è anche tanto altro: un appassionato studioso che cerca di coniugare impegno intellettuale e agire concreto nel segno della trasformazione del mondo e che si dichiara amico della nonviolenza. Il suo è un libro engagé. Con l’acribia filologica, che contraddistingue i suoi lavori più teorici, Cozzo concentra la propria attenzione sui registri stilistici, i linguaggi e i ragionamenti comparsi nei media italiani che hanno raccontato o, per meglio dire, tentato di raccontare la guerra in Ucraina. E nella prima parte del suo lavoro rintraccia contraddizioni, sviste e omissioni ad opera di opinionisti e intellettuali di grido che finiscono per viziare la neutralità dell’informazione e per veicolare un resoconto parziale e, soprattutto, incline a trasformarsi in mera propaganda.
Quotidiani e settimanali, telegiornali e trasmissioni di approfondimento, si prestano in tal modo a divulgare un messaggio che, con il pretesto di stare dalla parte dell’aggredito, instilla sistematicamente, a danno dell’opinione pubblica, il virus della violenza. L’analisi delle strategie di propaganda è lucida e rigorosa, in alcuni casi si concentra su articoli e argomentazioni di illustri filosofi come Umberto Galimberti o reporter di guerra come Francesca Mannocchi o editorialisti come Massimo Gramellini. Con un tono serrato ma rispettoso degli autori e delle autrici dei cui scritti si occupa, Cozzo opera un vero e proprio lavoro di smontaggio nel tentativo, riuscito, di dimostrare non solo la fallacia logica delle argomentazioni che vogliono convincere il lettore della necessità della guerra ma anche l’insensatezza di tutte quelle retoriche che propongono letture semplicistiche di una realtà globale sempre più complessa.
Spesso si tratta di retoriche che si limitano a focalizzare l’attenzione sul singolo individuo, Hitler o Putin che sia, attribuendo le cause di tutti i nostri problemi al soggetto che si presume incarni il male assoluto. Cozzo sottolinea che questo modo di procedere evita di prendere in considerazione il fatto che le guerre sono sempre il risultato di complesse cause strutturali o sistemiche. Indicando nel dittatore di turno la personificazione del male assoluto si finisce per cadere in quella trappola che già Hannah Arendt aveva evidenziato a proposito del caso Eichmann: il gerarca nazista “viene respinto in un’alterità sadica alla quale non si immagina nemmeno per un istante di poter appartenere. E la sua abiezione in fondo ci rassicura. Eichmann viene dichiarato un’eccezione immorale, che rende inutile fin dall’inizio comprendere in maniera preventiva i meccanismi che potrebbero in futuro fabbricare nuovi Eichmann. Accusare la modernità tecnica, la segmentazione amministrativa, l’inumanità burocratica diventa impossibile” (p. 42).
L’eccessiva semplificazione ci impedisce, per esempio, di cogliere nel loro giusto peso, le responsabilità dell’Occidente nell’attuale stagione di crisi sistemica planetaria, le sue posture neocoloniali e le sue pretese di rapina e di saccheggio delle risorse dei popoli del sud del mondo. E ci ostacola, forse, nell’esaminare a fondo la presunta ma, in verità, erronea pretesa che noi (sempre che si possa poi capire cosa vuol dire questo noi) siamo sempre dalla parte del giusto e della ragione. Questo non vuol dire assolvere le pulsioni di guerra dell’aggressore, significa tuttavia evitare che si possa cadere nel precipizio della sterile contrapposizione che, come insegnava Gregory Bateson, l’illustre epistemologo autore dell’Ecologia della mente, può condurre a forme perverse e distruttive di escalation simmetrica e senza senso. In fondo, il rischio di una guerra nucleare che precipiterebbe l’umanità verso la propria estinzione è sempre dietro l’angolo.

Compito dei grandi organi di informazione, e di tutti noi, dovrebbe essere quello di avere a cuore la pace e di indirizzare tutte le nostre energie per la risoluzione nonviolenta di ogni forma di conflitto. Cozzo propone la strada dell’equivicinanza: “diversamente da come vorrebbe l’accusa mossa, sulla base della dominante logica “a due uscite” (“o con una parte o con l’altra, altrimenti si è indifferenti o neutrali e si fa il gioco del più forte”), da chiunque non accetti l’esistenza di una logica diversa, è anch’essa (l’equivicinanza ndr.) uno schierarsi: è uno schierarsi per la concreta costruzione della pace mettendosi dalla parte delle vittime di entrambi i fronti belligeranti” (p. 70). Insomma, si tratta di valorizzare tutti quegli elementi di compartecipazione che possono fare sentire l’opinione pubblica vicina a tutte le parti vittime del conflitto e non solo accanto all’una o all’altra fazione della guerra.
Una volta esaurita efficacemente l’operazione di decostruzione dei dispositivi con i quali si costruisce un giornalismo e una comunicazione di guerra l’autore provvede, nella seconda parte del libro, ad avanzare la proposta relativamente a come dovrebbe e potrebbe essere un giornalismo e una comunicazione di pace. In questo si ispira alle stesse indicazioni del Consiglio d’Europa che, nella Risoluzione 1003, ribadisce che “i media hanno l’obbligo morale di difendere i valori della democrazia: rispetto della dignità umana e ricerca di soluzioni attraverso mezzi pacifici e in uno spirito di tolleranza; di conseguenza, devono opporsi alla violenza e al linguaggio dell’odio e dello scontro, rigettando ogni discriminazione fondata sulla cultura, sul sesso o sulla religione”. (p. 118).
Ma come rispondere concretamente a questa sollecitazione tanto semplice e chiara quanto difficile ed ardua da realizzare? È necessario, secondo Cozzo, lavorare in una prospettiva sistemica che possa produrre un cambiamento strutturale, in grado di coinvolgere istituzioni, cultura, economia, politica, società civile, in una dialettica riassumibile nello slogan tante volte citato ma forse poco praticato del pensare globalmente ed agire localmente: “la cultura in cui siamo allevati e viviamo ogni giorno non è una cultura di pace ma di competizione che fa da sponda perfetta alla logica della guerra – c’è uno che vince e uno che perde, e la parità è esclusa” (p. 148). Occorre allora ripensare probabilmente il nostro stile di vita, la mercificazione che satura ogni aspetto della nostra esistenza, l’estraneazione che costringe l’individuo a perdere la connessione e il legame con se stesso, con la propria storia e con la comunità nella quale si trova a vivere. C’è molto da fare, dunque, a partire dalla necessità di fare i conti con se stessi e con le proprie storture. Altro che scagliarsi contro un ipotetico nemico esterno.
Mi pare importante, infine, segnalare un’ultima questione che, tra le tante contemplate nel libro, gioca a mio avviso un ruolo centrale e strategico. Mi riferisco all’attenzione dedicata dall’autore alla preoccupante torsione autoritaria delle nostre democrazie nate, alla fine della seconda guerra mondiale, dalla Resistenza al nazifascismo. L’autore è persuaso, e sostiene questa sua convinzione con dovizia di argomentazioni e particolari, che i profili istituzionali delle nostre forme di governo stiano assumendo la forma di democrature. Con questo termine Cozzo vuole indicare il processo tendenziale in base al quale dietro la libertà formale del voto e dell’espressione del libero pensiero si nasconde uno svuotamento sostanziale di ogni processo di autentica partecipazione e di autentica sovranità. La libertà si rivela, in tal modo, più apparente che reale e finisce per sacrificare le altre due componenti essenziali dei nostri ordinamenti statuali, i valori della solidarietà e dell’uguaglianza. Si tratta di un problema scottante che chiunque abbia fatto un minimo di esperienza di impegno e di attivismo civile può dire di avere purtroppo esperito. Di fronte a questo problema epocale non sembra possano esserci facili soluzioni o semplici scorciatoie.
Cozzo, tuttavia, indica un sentiero preciso e piuttosto chiaro. Si tratta, in sostanza, di intendere, in ogni ambito della nostra esistenza, qui e ora, la pratica nonviolenta come una pratica di lotta consapevole che non esorcizzi il conflitto ma che lo sappia trasformare per renderlo produttivo e capace di apportare margini significativi di miglioramento per tutte le parti coinvolte. Allora, dice l’autore e in questo siamo concordi con lui, bisogna lottare: lottare in economia per un modo di produzione equo ed ecologico, lottare in politica per forme organizzative che favoriscano la partecipazione democratica di tutti, lottare nella società per una cultura capace di ascolto e in grado di esaminare i propri limiti. Soprattutto, per citare Capitini, bisogna lottare contro se stessi per mettere in discussione le proprie abitudini e le proprie certezze. Ed è per l’appunto citando il filosofo italiano della nonviolenza che vogliamo chiudere questo modesto contributo di riflessione; scrive Aldo Capitini: “è un errore credere che la nonviolenza sia pace, ordine, lavoro e sonno tranquillo, matrimoni e figli in grande abbondanza, nulla di spezzato nelle case, nessuna ammaccatura nel proprio corpo. La nonviolenza non è l’antitesi letterale e simmetrica della guerra: qui tutto infranto, lì tutto intatto. La nonviolenza è guerra anch’essa o, per dir meglio, lotta, una lotta continua contro le situazioni circostanti, le leggi esistenti, le abitudini altrui e proprie, contro il proprio animo e il subcosciente, contro i propri sogni, che sono pieni, insieme, di paura e di violenza disperata.” (175). Navighiamo in acque perigliose e tormentate e tuttavia non tutto è perduto. Non c’è più tempo da perdere e, sebbene il crescente caos intorno a noi stia avanzando sempre di più, non può rimanere più alcuno spazio per la rassegnazione e la passività.












