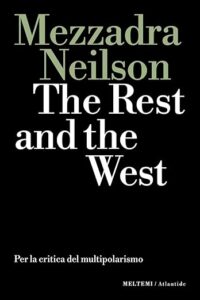La congiuntura attuale — segnata da guerra permanente, autoritarismo diffuso, militarizzazione delle economie e governo algoritmico della vita — non può essere interpretata come una semplice deviazione patologica dell’ordine occidentale. Essa rappresenta piuttosto la verità storica di una forma di universalismo che ha sempre prodotto unità attraverso la violenza, l’esclusione e la gerarchia.
In questo senso, la “crisi dell’Occidente” non è una perdita da rimpiangere, ma un punto di non ritorno teorico e politico. Come mostra con precisione Sandro Mezzadra, l’Occidente non va inteso come entità geografica, bensì come macchina storica di universalizzazione: un dispositivo che ha prodotto l’universale come norma armata, inseparabile dal colonialismo, dallo Stato-nazione e dal capitalismo globale.
Separare l’idea di universale dalla sua forma occidentale diventa allora il compito centrale della teoria politica contemporanea. Un compito che non è solo teorico, ma eminentemente organizzativo. La domanda decisiva non è più “quale soggetto?” o “quale identità?”, ma: come organizzare la convergenza di soggettività eterogenee senza ricadere nella sintesi sovrana o nella frammentazione impotente?
Una risposta decisiva si trova, sorprendentemente attuale, nella teoria dello sciopero di massa di Rosa Luxemburg. Nel suo scritto del 1906, Luxemburg rompe con ogni concezione strumentale dello sciopero, che per lei non è un atto delimitato deciso dall’alto, ma un processo storico vivo che emerge dalle contraddizioni materiali. La sua celebre metafora del fiume è centrale: lo sciopero raccoglie acque diverse — economiche, politiche, spontanee, organizzate — senza ridurle a un’origine unica. La sua forza sta nella composizione instabile. L’organizzazione non ne è la causa, ma un effetto secondario e sempre provvisorio. Questa intuizione consente di ripensare radicalmente l’organizzazione oggi: non come sorgente del conflitto, ma come pratica di manutenzione della sua continuità, contro i tentativi di arginamento messi in atto dal potere.
Nella fase contemporanea, segnata da regimi di guerra e autoritarismo, l’organizzazione politica non nasce più da identità pre-costituite — classe, popolo, nazione — ma da eventi di rottura che rendono intollerabile la normalità dominante. Questi eventi producono fratture nel senso comune, aprendo uno spazio di politicizzazione. Lo sciopero politico in Italia per la Palestina è esemplare in questo senso. Non è nato da una piattaforma ideologica condivisa, ma dalla visibilità insopportabile della violenza coloniale e genocidaria. L’organizzazione è emersa dopo, come tentativo di dare durata a una rottura che precedeva ogni identità collettiva. La lezione di Luxemburg si intreccia con quella di Gramsci: la crisi è il momento in cui il vecchio non regge più, ma il nuovo non ha ancora forma stabile. L’organizzazione non serve a chiudere la crisi, ma a impedirne la normalizzazione.
In questo caso, la Palestina non ha funzionato come “causa esterna”, ma come punto di condensazione: un nodo in cui contraddizioni diverse — guerra globale, sfruttamento del lavoro, razzializzazione dei confini, repressione del dissenso — si sono rese simultaneamente leggibili. Questa funzione evita due errori speculari: la gerarchizzazione delle lotte e la loro dispersione. Una lotta diventa centrale non per decreto, ma perché altre lotte vi riconoscono qualcosa di proprio. L’universale emerge qui non come principio astratto, ma come esperienza condivisa di intollerabilità. È precisamente questo il punto in cui la critica di Mezzadra all’Occidente diventa organizzativamente decisiva: l’universale non cancella i confini, ma li rende politicamente attraversabili. Non unifica, ma mette in relazione.
Lo sciopero per la Palestina ha prodotto una convergenza reale tra sindacalismo conflittuale, movimenti studenteschi, femminismi, reti migranti e attivismo anticoloniale. Tuttavia, questa convergenza non ha generato una fusione delle soggettività, né un programma unitario. Ciò che ha reso possibile l’azione comune è stato un processo continuo di traduzione: le differenze non sono state eliminate, ma rese operabili l’una per l’altra. La nozione di traduzione sostituisce definitivamente quella di rappresentanza. L’organizzazione non è il luogo della sintesi, ma lo spazio in cui le differenze vengono continuamente ritradotte, in un equilibrio instabile tra conflitto e cooperazione. Questa instabilità non è un limite: è la condizione stessa della potenza politica.
Per dare fondamento teorico a questa pratica, utilizziamo il lavoro dell’antropologia di Marilyn Strathern. In Strathern, le relazioni non connettono entità già date: le costituiscono. Il sociale è un pieno relazionale fatto di connessioni parziali. Applicata alla teoria politica, questa ontologia implica che l’universalismo non possa essere fondativo. L’universale non precede le differenze, ma emerge dalle loro relazioni. È un effetto, non un principio. Questo consente di pensare un altro universalismo: pratico, conflittuale, non occidentale. Un universalismo che non unisce cancellando, ma rende condivisibile senza equivalere.
La tradizione post-operaista ha mostrato come il capitalismo contemporaneo catturi direttamente cooperazione, linguaggio e affetti. Il comune è una produzione sociale. Tuttavia, senza una critica dell’Occidente, il comune rischia di essere reificato come sfondo ontologico neutro. L’approccio qui sviluppato, intrecciando post-operaismo e critica postcoloniale, restituisce al comune il suo carattere conflittuale e situato. Il comune non precede il conflitto: si produce dentro di esso.
Il sostegno alla Sumud Flotilla rappresenta un momento ulteriore di questo processo. Non si tratta di solidarietà umanitaria, ma di pratica politica universale non occidentale. La sumud — la perseveranza palestinese — diventa universalizzabile solo attraverso la relazione, non come valore astratto. Qui l’universale non parla per la Palestina, ma si produce con essa. È un universalismo che nasce dalla condivisione del rischio, dalla diserzione della neutralità occidentale, dalla messa in crisi del doppio standard imperiale.
Da queste pratiche emerge un elemento decisivo riguardo alla decisione. Non vi è stata rappresentanza permanente, né centro sovrano. Le decisioni sono state situate, parziali, reversibili. La legittimità non è derivata dalla delega, ma dalla responsabilità condivisa. Tuttavia, l’esperienza mostra anche un limite chiaro: senza infrastrutture autonome, la convergenza rischia di restare episodica. Organizzare significa dunque costruire le condizioni materiali della durata: strumenti di comunicazione non estrattivi, reti di mutuo soccorso, continuità tra eventi e processi.
La crisi dell’Occidente apre, dunque, una possibilità politica radicale: liberare l’universale dalla sua forma armata. Lo sciopero politico per la Palestina e il sostegno alla Sumud Flotilla mostrano che questo è possibile non come progetto astratto, ma come pratica concreta di convergenza. Organizzare oggi non significa produrre unità, ma sostenere processi-fiume; non significa rappresentare, ma tradurre; non significa fondare l’universale, ma produrlo relazionalmente. In tempi di guerra e autoritarismo, questa non è una posizione teorica neutra. È una presa di parte: per un contropotere capace di abitare il pieno delle differenze senza ricadere nell’Uno occidentale.
Bibliografia
Sandro Mezzadra, Brett Neilson The rest and the west. Per la critica al multipolarismo, Meltemi, 2025.
Rosa Luxemburg, Sciopero di massa, partito e sindacati, Editori Riuniti, 1970.
Marilyn Strathern,Partial Connections, Rowman & Littlefield, 1991.
Verónica Gago, La potenza femminista,O il desiderio di cambiare tutto, Meltemi, 2022.